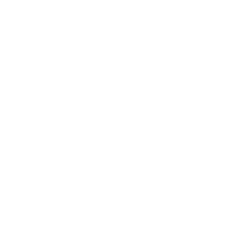Lessico
Porcellino di terra
Il porcellino di terra proviene in origine dalla regione atlantica e dell’Europa occidentale. Nel frattempo, questo crostaceo terrestre, che ha seguito l’uomo nelle sue migrazioni, si è insediato quasi in tutto il mondo ed è spesso presente anche nelle aree abitate dall’uomo. Nei giardini, il Porcellio scaber si trova, ad esempio, nella lettiera di foglie, nei cumuli di compost o sotto frammenti di corteccia. Sono presenti anche nei boschi, dove popolano in numerosissime colonie le lettiere. Il Porcellio scaber è un onnivoro e si nutre principalmente di piante vegetali in decomposizione.
Poiché i porcellini di terra svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell’humus, sono considerati animali utili, molto apprezzati soprattutto dai giardinieri amatoriali. Tuttavia, in alcune circostanze, possono causare danni a scorte vegetali come patate, carote o mele, quando vengono conservate in ambienti umidi come le cantine. In caso di un’abbondante proliferazione all’interno di serre, possono danneggiare i germogli e le giovani piante, arrivando talvolta a distruggerle.
In ambito domestico generalmente non è necessaria alcuna azione di intervento. I porcellini di terra che si introducono nelle abitazioni sono da considerarsi semplicemente fastidiosi, poiché, secondo le conoscenze attuali, non sono veicolo di alcuna malattia. Inoltre, il piccolo Porcellio scaber non è in grado né di mordere né di pungere. Tuttavia, qualora si ritenesse indispensabile un intervento, è possibile ricorrere sia a esche avvelenate che a insetticidi di contatto.

La cimice
La cimice dei letti misura tra i 4 e i 6 mm di lunghezza e presenta una colorazione che varia dal rossastro al marrone scuro. Le antenne sono composte da quattro segmenti, con un segmento basale relativamente corto. Gli occhi sono disposti lateralmente sulla testa, conferendo un aspetto peculiare a questo insetto. Un tratto distintivo sono le espansioni laterali del pronoto, che si evidenziano chiaramente. Il corpo è ricoperto da una fitta peluria, mentre zampe e antenne appaiono di colore giallastro. Le cimici dei letti non sono in grado di volare, in quanto conservano solo minuscole tracce di ali. Il lungo apparato boccale, adatto alla suzione, è generalmente nascosto sotto il corpo. Ogni giorno la femmina depone tra le 3 e le 5 uova, che vengono fissate con una secrezione solubile in acqua nei punti di sosta degli insetti, come fessure nei mobili, dietro i quadri, nelle prese elettriche, su abiti o tende. Nel corso della sua vita una singola femmina può deporre tra le 250 e le 300 uova.

Nutrizione e danni
Durante il giorno, le cimici dei letti si celano dietro tappezzerie allentate, nelle fessure e nelle crepe. La loro attività prende il via solo al calar della sera, attratte dal calore corporeo e dal biossido di carbonio emesso dall’uomo. Le cimici dei letti sono ectoparassiti che si nutrono di sangue. La loro diffusione è facilitata dai viaggi delle persone: aeroporti, mezzi di trasporto pubblici e persino autobus scolastici sono veicoli ideali per la loro propagazione. Una volta introdotte in una camera da letto si sviluppano facilmente. Sebbene non trasmettano malattie, le loro punture provocano un fastidioso e intenso prurito.
Come intervenire
Le cimici dei letti possono essere contrastate mediante l’uso di insetticidi di contatto, che vengono spruzzati nei rifugi diurni degli insetti (ad es. sotto tappezzerie, dietro quadri, nelle fessure dei mobili e nelle pieghe dei materassi). La maggior parte di questi preparati contiene piretroidi sintetici, che agiscono sul sistema nervoso delle cimici. L’ultimo principio attivo ad essere approvato nell’Unione Europea per il trattamento delle cimici dei letti, secondo la normativa sui biocidi, è il chlorfenapyr. In alternativa, le cimici dei letti possono essere eliminate attraverso l’utilizzo di alte temperature, che uccidono gli insetti e le loro uova.

La Blattella germanica
Le blattelle germaniche raggiungono una lunghezza che varia tra i 10 e i 15 mm e presentano una colorazione uniforme giallo-marrone. Sebbene le ali di questa specie siano significativamente più sviluppate rispetto a quelle dello scarafaggio comune, gli esemplari sono in grado di effettuare solo voli planati. Il pronoto è caratterizzato da due strisce scure disposte longitudinalmente. Le ooteche (capsule contenenti le uova), di forma piatta e delle dimensioni di circa 6×3 mm, sono di un colore che varia dal marrone chiaro al marrone medio.
Ciclo di vita
Le blattelle germaniche raggiungono una lunghezza che varia tra i 10 e i 15 mm e presentano una colorazione uniforme giallo-marrone. Sebbene le ali di questa specie siano significativamente più sviluppate rispetto a quelle dello scarafaggio comune, gli esemplari sono in grado di effettuare solo voli planati. Il pronoto è caratterizzato da due strisce scure disposte longitudinalmente. Le ooteche (capsule contenenti le uova), di forma piatta e delle dimensioni di circa 6×3 mm, sono di un colore che varia dal marrone chiaro al marrone medio.
Come intervenire
Le ooteche delle blattelle sono resistenti agli insetticidi e vengono deposte in luoghi difficilmente accessibili. Di conseguenza, la lotta contro questi insetti deve essere adattata al loro ciclo vitale e seguire procedure esatte. Gli intervalli di tempo tra le diverse misure di intervento devono essere attentamente pianificati, alternando regolarmente i principi attivi per prevenire l’insorgere di resistenze.
Il processo deve essere ripetuto fino alla completa eliminazione dell’infestazione. Purtroppo, non è possibile prevedere con certezza i tempi necessari per un controllo efficace.

La pulce
L’uomo può essere infestato da diverse specie di pulci, che possono essere introdotte nell’abitazione da lui stesso o da cani, gatti, uccelli e roditori. Tra queste ci sono la pulce dell’uomo, la pulce del gatto, la pulce del cane, la pulce della gallina, le pulce dei piccioni, la pulce del ratto e la pulce dei topi.
Aspetto
Le pulci, nella loro forma adulta e sessualmente matura, sono insetti privi di ali, generalmente di dimensioni comprese tra i due e i tre millimetri, con un corpo fortemente appiattito lateralmente. Le due coppie posteriori di zampe sono sviluppate come arti per il salto. Diversamente, ad esempio, dalle api o dalle mosche, le pulci non possiedono occhi composti altamente sviluppati, ma solo piccoli occhi semplici. Le antenne delle pulci sono molto corte e possono essere ripiegate all’interno di piccole cavità sulla testa. Tutte le specie di pulci presentano organi boccali particolarmente robusti, adatti a perforare e succhiare, grazie ai quali gli adulti si nutrono del sangue di animali a sangue caldo.
Ciclo vitale
Gli esemplari adulti di pulce, sia maschi che femmine, si nutrono di sangue almeno una volta al giorno. I principali ospiti parassitati sono i mammiferi, ma anche gli uccelli possono esserne infettati. Le zampe posteriori, fortemente sviluppate, consentono salti che possono raggiungere i cinquanta centimetri, un’abilità che riveste un’importanza fondamentale per la ricerca dell’ospite. Generalmente, le pulci visitano l’ospite solo per nutrirsi, per cui solo circa l’1% della popolazione totale di pulci (comprese le larve) si trova sull’animale a sangue caldo infetto. Le femmine di pulce depongono diverse centinaia di uova, che vengono solitamente lasciate in giacigli di animali, materassi, fessure del pavimento o tappeti. Pochi giorni dopo la deposizione, le uova si schiudono, dando vita alle larve. A differenza degli adulti, le larve non si nutrono di sangue, ma di detriti, muffa o feci delle pulci adulte. L’uscita dalla crisalide avviene solo in risposta a uno stimolo meccanico, di solito provocato dal movimento di un potenziale ospite. Se tale stimolo, normalmente causato dall’ospite, manca per un lungo periodo, la schiusura delle pulci adulte può essere ritardata per mesi. Questo spiega come, ad esempio, in un’abitazione che è rimasta vuota per un lungo periodo, si possa verificare una massiccia schiusa di pulci. In condizioni favorevoli, l’intero ciclo di sviluppo delle pulci può durare appena due settimane.
Come intervenire
Prima di iniziare il trattamento contro le pulci è necessario identificare il focolaio dell’infestazione, come ad esempio un animale domestico specifico. È essenziale determinare con precisione di quale specie di pulce tratti. La cattura delle pulci può avvenire tramite l’uso di un’apposita trappola che attira gli insetti grazie alla luce emessa, facendo sì che gli stessi restino poi attaccati a una superficie adesiva. Per il controllo delle pulci è possibile utilizzare diversi insetticidi di contatto, da spruzzare sulle superfici infestate, come ad esempio i tappeti. Questi preparati insetticidi contengono sostanze che danneggiano il sistema nervoso delle pulci, o inibitori dello sviluppo che provocano la morte delle uova e delle larve. Se cani o gatti sono infestati dalle pulci, è necessario avviare parallelamente alle misure di disinfestazione dell’abitazione un’adeguata terapia veterinaria per gli animali domestici.

La Blattella germanica
Il tarlo del legno è un coleottero di colore bruno-nero o nero, le cui antenne sono lunghe circa metà del corpo. I maschi di Hylotrupes bajulus possono raggiungere una lunghezza compresa tra i sette e i sedici millimetri, mentre le femmine sono mediamente più grandi, arrivando a misurare tra i dieci e i ventuno millimetri. Esse si distinguono dai maschi per la lunga e retrattile ovodepositrice che attraversa il corpo. Le larve di Hylotrupes bajulus, di colore biancastro, possono raggiungere i venticinque millimetri di lunghezza e, nei legni di conifera, tendono a danneggiare principalmente l’alburno. Un’infestazione da tarlo del legno è facilmente riconoscibile dal foro di uscita ovale che il coleottero lascia nel legno quando abbandona la pupa. Questo foro misura circa tre per sette millimetri. Un altro carattere distintivo sono i rumori di rosicchiamento prodotti dalle larve del tarlo del legno.
Distribuzione
La fase di accoppiamento e deposizione del tarlo del legno avviene tra luglio e agosto, durante i periodi di elevate temperature esterne. I tarli del legno vivono generalmente solo tre o quattro settimane e durante questo breve periodo cessano ogni attività alimentare. Una singola femmina può deporre fino a 1.000 uova. La deposizione avviene principalmente in fessure e cavità di legni di conifera oramai morti. Le larve, che si schiudono dopo due o tre settimane, scavano gallerie sempre più ampie, raggiungendo un diametro che può arrivare fino a dodici millimetri. Le temperature di circa 30°C e un’umidità del legno compresa tra il 40% e il 50% rappresentano le condizioni ideali per lo sviluppo delle larve. Tuttavia, anche in queste circostanze favorevoli, il loro ciclo di sviluppo richiede almeno due anni. In condizioni meno favorevoli, l’intero ciclo di vita dell’Hylotrupes bajulus può estendersi fino a dieci anni. La pupa si sviluppa sempre a pochi millimetri dalla superficie del legno.
Come intervenire
Il tarlo del legno colonizza principalmente il legno di conifera non trattato. All’interno degli edifici sono soprattutto le travi del tetto delle costruzioni più datate a esserne interessate. Se un’infestazione da Hylotrupes bajulus viene notata solo dopo anni, a causa della comparsa dei fori di volo, è spesso troppo tardi, poiché i danni sono già considerevoli. Durante un temporale le travi danneggiate dal tarlo del legno possono rompersi, provocando il crollo della struttura del tetto.
Nel caso venga accertata un’infestazione, è consigliabile consultare sempre un’impresa specializzata, la quale eseguirà prima una valutazione dell’entità del danno e successivamente adotterà le opportune misure di intervento più idonee. Le larve del tarlo del legno che abitano le travi del tetto possono essere eliminate mediante trattamenti ad aria calda o l’uso di insetticidi a contatto. Siamo a disposizione per fornire, su richiesta, i riferimenti di aziende specializzate nella valutazione e nel trattamento delle infestazioni da tarlo del legno nella vostra zona.

La martora
In Europa, la molto adattabile Martes foina è ampiamente diffusa. La martora è un tipico animale che si adatta alla civiltà e ha colonizzato anche le nostre grandi città. Sebbene la Martes foina appartenga all’ordine dei carnivori, consuma regolarmente anche alimenti di origine vegetale. La composizione della sua alimentazione cambia notevolmente durante l’anno: gran parte della sua dieta animale è costituita comunque da piccoli mammiferi, come ad esempio le arvicole, mentre durante l’estate e l’autunno il suo cibo principale consiste soprattutto in frutta, ma anche in cereali.
Ciclo di vita
La martora è nota anche per la sua attitudine a danneggiare i veicoli. Tuttavia, le martore possono anche trasmettere agenti patogeni e parassiti agli esseri umani o agli animali domestici come cani e gatti. Spesso le martore sono infestate da vermi piatti (Cestoda) o vermi a ventosa (Trematoda). Inoltre, le martore sono considerate vettori di malattie infettive, come la rabbia o la meningite.
Oltre ad essere un problema per la salute, la martora si fa notare come causa di danni considerevoli a veicoli parcheggiati, dove morde cavi, parti in gomma o plastica. Per via del loro comportamento notturno, le martore che si rifugiano, ad esempio, in soffitta, possono diventare molto fastidiose, disturbando il sonno dei residenti. Inoltre, le feci e i resti delle loro prede attirano mosche e altri insetti dannosi.
Come intervenire
Sono disponibili in commercio diversi repellenti, efficaci nel tenere lontano le martore da soffitte e veicoli parcheggiati. Molti di questi prodotti contengono il principio attivo di alluminio ammonio solfato, una sostanza che, oltre a essere impiegata come additivo alimentare e agente lievitante, risulta particolarmente sgradita alle martore a causa del suo sapore estremamente amaro, che le allontana. Una volta che l’uso di tali repellenti ha permesso di scacciare le martore dalle soffitte, è fondamentale sigillare eventuali punti di accesso, per garantire l’allontanamento permanente della Martes foina. La cattura di singoli esemplari, invece, non rappresenta una soluzione duratura, poiché i territori lasciati vacanti vengono solitamente prontamente rioccupati.
Nel processo di cattura delle martore è necessario rispettare le disposizioni della normativa venatoria, osservando, ad esempio, le fasi di protezione previste per legge.

Topi e ratti
Una caratteristica comune di questi roditori è la loro straordinaria velocità con cui si riproducono in condizioni favorevoli. A partire da una coppia di ratti, la popolazione può crescere di oltre 840 esemplari in un solo anno, mentre per i topi la prole può arrivare fino a 2.000 esemplari.
Danni
Ratti e topi causano danni agli edifici e, attraverso il loro rosicchiare e le loro deiezioni, compromettono anche alimenti e arredi. Non di rado i cavi elettrici rosicchiati possono provocano incendi. Questi roditori continuano a essere veicoli di malattie, tra cui salmonella, rabbia e tubercolosi. Il virus più temuto è l’hantavirus, trasmesso attraverso urine e feci, con un rischio particolarmente elevato di contaminazione nei parchi giochi, come nei box di sabbia. Per questo motivo è di fondamentale importanza adottare misure tempestive ed efficaci per la lotta contro questi roditori all’interno degli edifici.
Prevenzione e come intervenire
La condizione igienica rappresenta un requisito essenziale per il successo di qualsiasi intervento contro topi e ratti. Questo principio deve essere applicato non solo agli ambienti interni dell’edificio, ma anche alle aree esterne, in particolare ai contenitori per i rifiuti, che devono essere adeguatamente coperti e non devono presentare rifiuti sparsi nei dintorni.
Per garantire un’efficace difesa contro questi roditori, è essenziale che esperti del settore effettuino ispezioni periodiche e forniscano indicazioni precise per una corretta gestione igienica. Eventuali carenze devono essere affrontate immediatamente per non compromettere il successo dell’intervento.
Le misure isolate contro topi e ratti raramente portano a risultati duraturi. È necessario impiegare esche fresche e attrattive per gli animali, che dovranno essere periodicamente posizionate da professionisti. Inoltre, per evitare che i roditori sviluppino resistenza ai principi attivi, è fondamentale cambiare regolarmente i principi attivi utilizzati.

Acari della polvere
Gli acari della polvere, appartenenti alla famiglia degli aracnidi, si nutrono prevalentemente di cellule di pelle desquamata, delle quali ogni persona ne perde quotidianamente circa uno o due grammi. La loro dimensione microscopica, che misura appena 0,1 mm, li rende praticamente invisibili ad occhio nudo.
Ciclo vitale
A seguito dell’accoppiamento, le femmine depongono le uova nel corso di un periodo prolungato in maniera sparsa e graduale, piuttosto che in un unico nido. La durata della vita delle femmine dipende fortemente dalla temperatura e dall’umidità ambientale, oltre che dalle peculiarità della specie, variando tra i 30 e i 100 giorni. Durante questo periodo ogni esemplare femminile depone tra 40 e 80 uova, che si evolvono attraverso uno stadio larvale e successivi stadi ninfali, per giungere infine a maturazione sessuale. Il ciclo vitale complessivo, dall’uovo all’acaro adulto, è estremamente variabile: in condizioni favorevoli può durare dai 30 ai 50 giorni, ma in presenza di temperature più basse può estendersi fino a 120 giorni.
Come intervenire
Un’infestazione di alimenti e derrate può essere evitata attraverso una corretta conservazione, mantenendo la merce in ambienti asciutti, poiché gli acari non tollerano condizioni di scarsa umidità. Qualora gli acari si presentino in silos o magazzini alimentari, è possibile impiegare per un’efficace disinfestazione diverse sostanze acaricide in forma gassosa, come ad esempio azoto, anidride carbonica e fosfina (idrogeno fosforato). Per ottenere una lotta efficace contro le fasi ninfali particolarmente resistenti, è fondamentale ripetere il trattamento a intervalli di circa due settimane. Anche l’uso della terra di Diatomee si sta rivelando una strategia promettente nella lotta contro gli acari.

La tarma del cibo
La tignola fasciata delle derrate, che appartiene alla famiglia delle farfalle, raggiunge una lunghezza di circa 6-9 millimetri, con un’apertura alare che misura all’incirca tra i 15 e i 20 millimetri. Quando è in stato di riposo, con le ali ripiegate, assume la forma di un triangolo appuntito di colore rosso-bruno o bronzato, attraversato centralmente da una larga striscia argentata. La larva di Plodia interpunctella, poco prima della trasformazione in crisalide, misura tra i 14 e i 17 millimetri di lunghezza. La sua colorazione può variare, a seconda dell’alimentazione, dal bianco al verde fino al rosso. In inglese è conosciuta come indian meal moth.
Ciclo di vita
L’habitat prediletto della tignola fasciata delle derrate comprende silos, magazzini, mulini, stabilimenti alimentari, supermercati, nonché cucine e dispense domestiche. L’introduzione di questa specie avviene frequentemente tramite il trasporto di cibi contaminati, ma anche attraverso il cibo per animali. Dopo l’accoppiamento, una femmina di tignola fasciata depone tra le 200 e le 400 uova, generalmente direttamente sul substrato alimentare destinata alle larve. Queste fonti possono comprendere frutta secca, muesli, frutta secca mista, cioccolato alle nocciole o alle mandorle, cereali e prodotti derivati, nonché pistacchi, ceci e miglio. Di norma, la specie attraversa cinque stadi larvali, ma talvolta ne raggiungerne anche sette. Al termine della fase di nutrimento, la larva entra in una fase migratoria di 3-10 giorni, al termine della quale si costruisce un bozzolo in un luogo protetto e si trasforma in pupa. Successivamente, all’interno della pupilla, avviene la metamorfosi in farfalla. In ambienti riscaldati la farfalla emerge circa due settimane dopo, mentre in silos di grano non riscaldati, a causa delle basse temperature, può verificarsi una diapausa che dura diversi mesi. A causa di questa fase di inattività nella pupilla, nei magazzini alimentari non riscaldati dell’Europa centrale si sviluppano solo 2 o 3 generazioni di Plodia interpunctella all’anno, mentre in ambienti riscaldati è possibile un numero significativamente maggiore di generazioni.
Come intervenire
Per accertare con sicurezza un’infestazione da tignola fasciata delle derrate vengono utilizzate apposite trappole adesive contenenti feromoni. Questi feromoni attraggono esclusivamente i maschi delle farfalle, che rimangono intrappolati sulla superficie adesiva. Per tale motivo, la sola applicazione di trappole a feromoni non è sufficiente per un’efficace lotta contro l’infestazione. Il feromone impiegato non è percepibile dall’uomo. In base alle differenti indicazioni dei produttori, la trappola può essere utilizzata per diverse settimane. In caso di comparsa delle tignole fasciate nei locali domestici è necessario esaminare attentamente gli alimenti conservati per verificare la presenza di infestazioni. Gli alimenti contaminati non sono più idonei al consumo e devono essere prontamente smaltiti. Un trattamento termico degli alimenti, riscaldandoli per un’ora a una temperatura compresa tra i 60° e i 70°C o congelandoli per uno o due giorni, uccide sia le farfalle che le loro larve; tuttavia, non tutti i tipi di scorte alimentari possono essere trattati in questo modo.
Oltre alla tignola fasciata delle derrate, le tarme più frequentemente riscontrate includono la tarma del grano, la tarma della farina, la tignola del cacao e la tarma dei tessuti.

Zanzare
Le zanzare, come la zanzara comune, possiedono un unico paio di ali. Il secondo paio è stato trasformato in piccole strutture sensoriali, noti come bilancieri, che svolgono una funzione di equilibrio. Un tratto distintivo delle zanzare è la lunga proboscide, che le femmine utilizzano per succhiare il sangue. Gli occhi di questi insetti sono relativamente grandi e le loro zampe si distinguono per la notevole lunghezza. La maggior parte delle zanzare adulte ha una lunghezza corporea compresa tra i cinque e i dieci millimetri. Le larve di zanzara, invece, appaiono completamente diverse dagli adulti: vivono in ambienti acquatici e trascorrono la maggior parte del tempo ancorate alla superficie dell’acqua mediante un tubo respiratorio situato alla fine del loro addome.
Ciclo di vita
I maschi di zanzara comune si nutrono esclusivamente di nettare o succhi vegetali; anche le femmine si alimentano di nettare, ma, per riprodursi e deporre le uova, è indispensabile che esse succhino il sangue di un vertebrato. La maggior parte delle specie di zanzare infesta mammiferi e uccelli, però anche l’essere umano è frequentemente utilizzato come ospite da questi fastidiosi insetti. Le larve di zanzara filtrano dall’acqua particelle organiche sospese, alghe o protozoi, mentre lo stadio pupale, che vive anch’esso in acqua, non si nutre più.
Le zanzare sono vettori di malattie infettive pericolose come la dengue, la febbre gialla e la malaria. Inoltre, questi insetti trasmettono regolarmente anche vermi parassitari, come quelli del genere filaria. La zanzara comune, presente anche in Germania, può essere portatrice di virus come il Sindbis virus, il virus del Nilo occidentale e il virus della febbre della Rift Valley.
Come intervenire
La lotta contro le larve di zanzara, che si sviluppano nell’acqua, risulta essere la più efficace. Gli insetticidi contenenti il principio attivo naturale Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) possono essere aggiunti a piccole raccolte d’acqua per il controllo delle zanzare, come le cisterne per l’acqua piovana o gli stagni. Nelle acque trattate il principio attivo si distribuisce nell’ambiente acquatico e viene assorbito dalle larve. L’efficacia del Bacillus thuringiensis israelensis è rapida, e nel giro di pochi giorni le larve di zanzara muoiono, senza danneggiare però pesci o altri esseri acquatici. I prodotti a base di Bacillus thuringiensis possono essere utilizzati anche nella protezione biologica delle piante, grazie alla loro azione altamente selettiva. Per la lotta contro le zanzare adulte, invece, è possibile ricorrere a vari spray insetticidi di contatto, che agiscono direttamente sugli insetti.

Lo scarafaggio nero
In Europa centrale, la Blatta orientalis si trova particolarmente bene in ambienti umidi e caldi, con almeno il 60% di umidità relativa dell’aria. Tali ambienti comprendono cucine industriali, panifici, aziende alimentari, mense, piscine, centri di accoglienza, ospedali, serre e servizi igienici pubblici, ma la presenza dello scarafaggio nero è comune anche nelle abitazioni private. Poiché, rispetto alla Blatta germanica, la Blatta orientalis ha inferiori capacità di arrampicata, i suoi rifugi sono generalmente nella zona del pavimento, in murature danneggiate, dietro rivestimenti di pareti, telai di porte, battiscopa, in condotti e tubazioni fognarie. Sebbene la temperatura ideale per la Blatta orientalis sia tra i 20 e i 29°C, la sua proliferazione è possibile anche a temperature inferiori, fino a 15°C. c
Effetti dannosi
A causa del suo stile di vita, lo scarafaggio nero può diffondere agenti patogeni che potrebbero infettare esseri umani, animali domestici e animali da allevamento. Inoltre, viene considerata un vettore di spore di funghi. Studi di laboratorio hanno dimostrato che i patogeni possono rimanere attaccati al corpo delle blatte fino a tre giorni, mantenendo la loro infettività durante questo periodo. Inoltre, la Blatta orientalis può diffondere patogeni anche attraverso le feci e il contenuto della sua ingluvie. Come altre specie di blatte (comunemente chiamate scarafaggi), la Blatta orientalis può provocare allergie. Sostanze allergeniche, presenti tra l’altro nelle feci della Blatta orientalis, possono scatenare quella che è conosciuta come allergia alla polvere domestica. La Blatta orientalis, tuttavia, non è solo un portatore di parassiti, ma riveste anche un ruolo dannoso per i materiali. In particolare, sono vulnerabili le apparecchiature tecniche, poiché lo scarafaggio nero tende a infiltrarsi in dispositivi elettronici come i computer, provocando così malfunzionamenti.
Come intervenire
Esistono diverse strategie per combattere la Blatta orientalis. Le trappole adesive, impregnate con attrattivi, esercitano un doppio ruolo: oltre a catturare larve e individui adulti consentono di valutare l’entità dell’infestazione. Per tale motivo esse vengono comunemente impiegate dagli esperti di disinfestazione nel monitoraggio delle blatte. L’efficacia dei gel esca persiste per diverse settimane. Se utilizzata correttamente, questa tecnica di lotta non presenta rischi per l’uomo e gli animali domestici. Tuttavia, per eliminare definitivamente un’infestazione di Blatta orientalis, è fondamentale ripetere l’applicazione dell’esca alimentare nell’arco di diversi mesi, anche se le blatte non sono più visibili dopo breve tempo. Solo così si garantisce che anche le larve, che si schiudono dalle ooteche (pacchetti di uova) solo dopo l’inizio delle operazioni di disinfestazione, vengano eliminate in modo efficace.

Tribolio delle farine
Il tribolio delle farine appartenente alla famiglia dei tenebrionidi (Tenebrionidae), può raggiungere una lunghezza di 5,5 millimetri e una larghezza massima di 1,5 millimetri. Il Tribolium destructor nel suo aspetto è relativamente sottile.
Ciclo di vita
La specie, originariamente proveniente probabilmente dall’India, si trova in Europa soprattutto in mulini, panifici e nelle abitazioni come parassita delle scorte alimentari. Il tribolio delle farine attacca infatti vari tipi di derrate alimentari. Un’indagine di laboratorio ha rilevato che il Tribolium destructor può riprodursi nei seguenti substrati alimentari: cereali spezzati (riso, grano, avena), mais, crusca di grano, nocciole, noci, arachidi e mandorle. Al contrario, il tribolio delle farine non si sviluppa su chicchi di cereali intatti, ad eccezione del mais. L’intero ciclo di sviluppo o dura circa 44 giorni a una temperatura di 25°C e con un’umidità relativa dell’aria del 75%.
Il tribolio delle farine predilige principalmente cereali spezzati o cereali già danneggiati da altri parassiti come il cappuccino dei cereali (Rhizopertha dominica). Oltre che nei cereali e nei prodotti a base di cereali come la farina, il Tribolium destructor è stato trovato anche in prodotti da forno, fiocchi di patate, pasta, croccantini per cani, mangime per uccelli e crusca. Le derrate infestate vengono contaminate dalle feci di questi coleotteri, nonché dalla fine polvere prodotta dalle loro attività di nutrimento.
Come intervenire
Le scorte confezionate infestate dal tribolio delle farine possono essere trattate con insetticidi gassosi come il diossido di carbonio o l’idruro di fosforo. Nei mulini o nei panifici questo parassita delle derrate può essere controllato anche mediante l’applicazione di aria calda. L’utilizzo di alte temperature contro insetti dannosi come il Tribolium destructor è una pratica consolidata nella protezione delle scorte alimentari. In linea generale si ritiene che, a una temperatura di 60°C, un’esposizione di un’ora porta alla completa morte di tutte le fasi di sviluppo dell’insetto. Quando si impiega questo metodo termico, per un trattamento efficace è fondamentale garantire che tutte le aree dell’ambiente raggiungano la temperatura necessaria, perché in caso contrario, alcuni esemplari del tribolio delle farine potrebbero sopravvivere nelle zone più fredde. Per il trattamento di magazzini vuoti possono essere utilizzati preparati antiparassitari contenenti principi attivi come il piretro o la terra di Diatomee.

Il ghiro
I ghiri, nel periodo autunnale, tendono a cercare rifugio all’interno di abitazioni e dispense, ambienti che trovano particolarmente confortevoli e dove possono persino trascorrere il loro letargo. È fondamentale adottare precauzioni nelle misure di contenimento, in quanto questi animali sono protetti dalla legge. I ghiri sono lunghi da 12 a 19 cm. La loro coda può arrivare a una lunghezza di 11-16 cm ed è folta. La parte superiore del corpo è di colore blu-grigio e leggermente annerita, mentre la parte inferiore è bianca. Oltre alla coda, ciò che distingue il ghiro da un comune topo è la grandezza notevole dei suoi occhi.
Ciclo di vita
Durante il giorno, i ghiri, essendo animali notturni, riposano, mentre di notte si dedicano alla ricerca di ghiande, nocciole, castagne, bacche, frutta e insetti. Tra giugno e agosto nasce la loro prole, composta da tre a cinque piccoli ghiri ciechi. Il periodo di letargo invernale va da metà ottobre a marzo e preferiscono trascorrerlo in compagnia. Nei frutteti i ghiri causano danni soprattutto mordicchiando la corteccia degli alberi giovani, ma possono diventare rapidamente un problema anche all’interno degli edifici. Rosicchiano infatti diversi materiali, tra cui legno, tessuti, plastiche e cavi isolati, arrivando talvolta a distruggerli completamente. Per prevenire l’insediamento all’interno degli edifici è necessario intervenire con misure strutturali, come l’installazione di reti metalliche o pannelli forati. Poiché i ghiri sono protetti dalla legge, l’unica soluzione consentita per il loro controllo è l’uso di trappole per catturarli vivi e l’impiego di repellenti.
Come intervenire
Il ghiro è una specie particolarmente protetta. È vietato perseguitare, catturare, ferire, uccidere animali selvatici appartenenti a specie protette, nonché prelevare, danneggiare o distruggere i loro stadi di sviluppo, i luoghi di nidificazione, riproduzione, rifugio o di abitazione nella natura. La violazione di queste disposizioni può comportare una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 50.000 euro. Le eccezioni o le esenzioni dalle disposizioni di protezione possono essere concesse esclusivamente dalle autorità competenti in materia di conservazione della natura e tutela del paesaggio. Ciò implica che l’uso di trappole per la cattura dei ghiri vivi o il loro abbattimento sia generalmente subordinato al rilascio di un’autorizzazione specifica.

Pesciolino d‘argento
I pesciolini d’argento appartengono al gruppo degli insetti primitivi. A differenza della maggior parte degli altri insetti, queste specie non possiedono ali. Questi animali misurano tra i 7 e i 12 mm di lunghezza e presentano antenne lunghe e filiformi. La parte toracica appare visibilmente più larga, mentre l’addome si restringe progressivamente verso la parte terminale. Alla fine del corpo si notano tre prolungamenti filiformi e setolosi: due cerci laterali e uno centrale. Il nome comune deriva dalla particolare copertura squamosa che ricopre l’intero corpo dell’insetto, con un caratteristico riflesso argenteo dovuto alla riflessione della luce.
Ciclo di vita
Il pesciolino d’argento è attivo di notte e in Europa centrale si trova esclusivamente negli appartamenti, poiché dipende da un clima caldo e umido. Questi insetti possono cambiare pelle da 20 a 40 volte e raggiungere un’età compresa tra i 2 e i 5 anni. La temperatura ottimale per il loro sviluppo è tra i 25 e i 30°C, con un’umidità relativa dell’80-90%. I pesciolini d’argento si trovano principalmente nei luoghi scuri e caldi di appartamenti umidi, mentre all’aperto possono anche colonizzare i nidi degli uccelli. La loro alimentazione si basa su materiali ricchi di amido e zucchero (ad esempio zucchero grezzo). Questi insetti sono anche in grado di digerire materiali contenenti cellulosa.
Il Lepisma saccharina è considerato un portatore di parassiti ed è dannoso per i materiali. Provoca danni a oggetti consistenti, come copertine di libri, con segni di raschiatura. Su superfici come carta da parati, carta o cartone può invece causare fori. Inoltre, si nutre di materiali contenenti amido o zucchero, come farina, semolino o fiocchi d’avena e può così contaminare gli alimenti con germi patogeni per l’uomo. Il pesciolino delle case (Thermobia domestica), strettamente imparentato, non è così diffuso come il Lepisma saccharina e si trova principalmente nelle panetterie.
Come intervenire
Se i pesciolini d’argento si manifestino all’interno di un’abitazione, è opportuno iniziare con l’impiego di trappole adesive per valutare l’entità dell’infestazione. Per il trattamento vero e proprio si consigliano insetticidi a contatto, da applicare in particolare nei rifugi più nascosti degli insetti. I principi attivi più comunemente utilizzati sono i piretroidi sintetici, che agiscono in modo simile al prodotto naturale del piretro, derivato dai crisantemi. Per ulteriori dettagli sulla gestione dei pesciolini d’argento si rimanda alla nostra pagina dedicata alla lotta contro i parassiti.

Il pidocchio della polvere
I pidocchi della polvere (Psocoptera) sono presenti in circa un terzo delle abitazioni tedesche, dove si trovano frequentemente tra i libri, sugli alimenti a base di cereali, su vecchi cartoni per uova o sulle tappezzerie di colore chiaro. In tali ambienti il loro ciclo di sviluppo può durare solo nove giorni. Una femmina, nel corso della sua vita, depone circa 100-110 uova che vengono prodotte durante tutto l’anno all’interno degli edifici, con la possibilità che si sviluppino da sei a otto generazioni annuali. La durata della vita di un pidocchio della polvere è di circa dieci-dodici settimane. Si nutrono principalmente di colonie di muffa che si sviluppano su pareti umide o su alimenti. I prodotti a base di cereali offrono loro condizioni di vita particolarmente favorevoli, mentre legumi, polvere d’uovo, pasta o latte in polvere ne sono raramente infestati.
Ciclo di vita
I pidocchi della polvere (Psocoptera) non si nutrono direttamente di alimenti, bensì di colonie di muffa che si sviluppano a causa dell’umidità elevata sugli alimenti conservati. Pertanto, essi sono principalmente considerati portatori di parassiti. I pidocchi della polvere sono estremamente resilienti e possono proliferare, ad esempio, anche in tisane confezionate ermeticamente. Gli alimenti infestati non sono più adatti al consumo umano e devono essere prontamente smaltiti. Questi insetti si trovano principalmente in ambienti umidi, come appartamenti di nuova costruzione, biblioteche, cantine, ma anche su materiale organico esposto in cucine o dispense, nonché in stanze con piante da interno. Negli appartamenti appena tappezzati o in quelli appena ristrutturati e umidi, si verifica spesso una massiccia proliferazione. I pidocchi della polvere si nutrono dello strato di muffa poco visibile presente sulle pareti e lasciano dietro di sé una sottile polvere di carta. È altamente probabile che i pidocchi della polvere, come gli acari della polvere, possano essere responsabili di reazioni allergiche. Studi medici hanno rivelato la presenza di anticorpi contro gli antigeni dei pidocchi della polvere nel sangue di un terzo dei pazienti affetti da allergie.
Come intervenire
In caso di infestazioni massicce di pidocchi della polvere (Psocoptera) si può ricorrere all’uso di insetticidi di contatto, i quali contengono come principi attivi, per lo più, piretroidi sintetici. Tali sostanze agiscono come veleni di contatto che inducono inizialmente una forte eccitazione nei pidocchi, seguita da una paralisi, spesso irreversibile, e infine dalla morte. Sia il piretro naturale, sia i piretroidi sintetici derivati condividono un meccanismo d’azione comune: bloccano i canali dal sodio dipendenti dalla tensione nelle membrane nervose dei pidocchi della polvere.
Per una lotta efficace e duratura contro i pidocchi della polvere è essenziale rimuovere la loro fonte di nutrimento.

La mosca domestica
La mosca domestica predilige come substrato di riproduzione materiali vegetali in decomposizione. Condizioni ideali per lo sviluppo delle sue larve si trovano, ad esempio, in cumuli di compost contenenti rifiuti organici, stalle, discariche, mucchi di letame e contenitori per i rifiuti. Un chilogrammo di letame di maiale può contenere fino a 15.000 larve di mosca domestica. Gli adulti di Musca domestica si nutrono esclusivamente di cibi liquidi, che riescono ad assorbire grazie al loro apparato boccale a proboscide, come latte, succhi di frutta o umidità presente su carne e altri alimenti. Una femmina può deporre tra le 600 e le 2.000 uova nel corso della sua vita. La durata dello sviluppo larvale è influenzata dalla temperatura; durante l’estate, dal momento della deposizione delle uova alla nascita della mosca adulta (imago), trascorrono generalmente 2-3 settimane. Durante una singola stagione vegetativa si possono sviluppare 8-10 generazioni di mosche: teoricamente, una singola femmina potrebbe produrre fino a 250 trilioni di discendenti in un anno. In ambienti che offrono condizioni favorevoli di vita, costanti durante tutto l’anno, come ad esempio panifici o impianti di allevamento, la specie può continuare a riprodursi anche durante l’inverno. All’interno degli edifici, la mosca domestica tende a preferire determinati luoghi di sosta, facilmente riconoscibili per presenza di un’alta concentrazione di mosche, in particolare nelle aree in cui si accumulano escrementi. La mosca domestica è un insetto diurno.
Le mosche domestiche rappresentano un serio rischio in quanto vettori di pericolose malattie infettive. Possono trasmettere, ad esempio, i patogeni della dissenteria batterica, della febbre tifoide e paratifoide, nonché della dissenteria amebica ed è possibile anche la diffusione delle uova di tenia. Un’infestazione massiccia di questi insetti può comportare conseguenze economiche significative per gli agricoltori: in caso di infestazione da mosche, le mucche producono circa un quinto di latte in meno, mentre i maiali aumentano di peso in modo più lento. Per prevenire una proliferazione delle mosche è fondamentale conservare gli alimenti in contenitori ben chiusi. Anche per quanto riguarda i bidoni della raccolta dei rifiuti organici, è importante assicurarsi che il coperchio sia sempre ben chiuso. L’installazione di zanzariere alle finestre si rivela una misura altamente efficace per impedire l’ingresso della mosca domestica nelle abitazioni.
Come intervenire
Per un intervento diretto contro la Musca domestica risultano particolarmente utili le lampade UV, le trappole per mosche, gli spray insetticidi e le strisce adesive. In particolare, le lampade UV, se utilizzate correttamente, si distinguono per la loro ecocompatibilità e sicurezza per l’utente, rendendole particolarmente adatte per ambienti come stabilimenti di trasformazione alimentare o ristoranti. Le mosche domestiche vengono attratte dalla luce ultravioletta emessa dalla lampada e volano verso di essa; una volta vicine, vengono eliminate da una griglia ad alta tensione o rimangono attaccate a una superficie adesiva. Poiché anche insetti utili, come le api mellifere, vengono attratti e uccisi, è opportuno evitare l’uso delle lampade UV all’esterno.

Piccioni
I piccioni domestici inselvatichiti, noti anche come piccioni di città, sono ormai parte integrante del paesaggio urbano in molte delle principali città di tutto il mondo, dove, da decenni, formano numerose colonie per la nidificazione, il riposo e l’alimentazione. Il nido del Columba livia domestica è costruito con pochi rami e viene generalmente edificato su soffitte o sulle facciate degli edifici. Affinché ciò avvenga, però, i cornicioni delle facciate devono avere una larghezza di almeno dieci centimetri e devono offrire protezione dalla pioggia diretta. Ogni anno possono esserci fino a quattro cicli di cova, con due giovani piccioni per ciclo. L’alimentazione del piccione domestico è prevalentemente a base di cereali e derivati, ma il piccione non disdegna di nutrirsi di qualsiasi tipo di alimento umano, come pasta, pesce e anche cioccolato.
Ciclo di vita
Nei luoghi in cui il Columba livia domestica nidifica o si riposa, la continua deposizione di escrementi rende necessari costosi interventi di pulizia e restauro su tetti e facciate. I piccioni inselvatichiti (comunemente conosciute come piccioni di città) sono in grado di trasmettere oltre 100 patogeni che possono infettare sia gli esseri umani che gli animali domestici, tra cui virus, batteri, funghi, protozoi, vermi piatti e cilindrici, nonché numerose specie di insetti, zecche e acari. Gli escrementi di piccione giocano un ruolo cruciale nella diffusione di malattie, poiché forniscono un ambiente ideale per la proliferazione di muffe e funghi. Per queste ragioni, il piccione domestico è considerato sia un portatore di parassiti che dannoso per i materiali. Inoltre, nei suoi nidi proliferano numerose specie di insetti e acari che vengono anch’essi classificati come portatori di parassiti e dannosi per i materiali.
Come intervenire
Esistono diversi sistemi di dissuasione meccanica, studiati per impedire che i piccioni selvatici si posino su sporgenze, grondaie e simili, evitando così che vi si fermino per riposarsi o nidificare. Tra i metodi più utilizzati ci sono le apposite punte anti-uccelli in acciaio inox, progettate per tenere lontani i piccioni di città. Tale intervento consente di prevenire, almeno in parte, l’inquinamento delle facciate degli edifici da escrementi di piccione. È importante sottolineare che, per motivi legali, la lotta diretta al piccione domestico è possibile solo previo ottenimento di un’autorizzazione speciale.

Il coleottero dei tappeti
I piccoli coleotteri scuri appartenenti alla famiglia dei dermestidi (Dermestidae) raggiungono una lunghezza corporea di circa 2-3 mm. Sulle elitre dell’Anthrenocerus australis sono visibili tre linee a zig-zag indistinte, formate da setole bianche. Le antenne sono composte da 11 segmenti, con i tre ultimi che formano una clava ben definita, risultando complessivamente di pari lunghezza rispetto ai restanti otto segmenti. La larva del coleottero dei tappeti raggiunge una lunghezza compresa tra 3 e 6 mm, presentando una colorazione bruna sulla parte superiore e giallo-bianca su quella inferiore.
Ciclo di vita
Il coleottero dei tappeti, a una temperatura ambiente media di 22°C, sviluppa da 2 a 3 generazioni all’anno. In tali condizioni, la schiusa degli insetti avviene durante tutto l’anno, ad eccezione dei mesi che vanno da novembre a febbraio. Nella loro terra d’origine, in Australia, questi coleotteri si trovano sulle fioriture, dove si nutrono di polline. Nelle nostre latitudini, sembra che l’intero ciclo di sviluppo dell’Anthrenocerus australis avvenga esclusivamente all’interno degli edifici, poiché non sono stati segnalati ritrovamenti all’aperto.
Le larve del coleottero dei tappeti danneggiano un ampio ventaglio di prodotti di origine animale, come tessuti di lana, pellicce, pelli e cuoio, grazie alla loro capacità di digerire ad es. la cheratina presente nei peli. Possono anche causare danni significativi alle collezioni entomologiche. All’interno delle abitazioni, le larve di Anthrenocerus australis si rifugiano sotto i tappeti e negli angoli bui degli armadi.
Come intervenire
Per prevenire un’infestazione da parte del coleottero dei tappeti è fondamentale effettuare una pulizia approfondita e regolare degli ambienti domestici. Questo aiuta a prevenire l’accumulo di polvere e peli, che potrebbero servire da substrato di nidificazione per questa specie e altri parassiti dei tessuti. Inoltre, la presenza di animali morti nei soffitti, come ad esempio topi o insetti disidratati, può rappresentare una fonte di nutrimento per l’Anthrenocerus australis. Per un’efficace lotta contro i coleotteri e le larve, è possibile ricorrere all’uso di insetticidi di contatto. Ulteriori informazioni su come contrastare il coleottero dei tappeti e altri parassiti dei tessuti sono disponibili nella nostra sezione dedicata alla lotta contro gli infestanti.

La formica
Le formiche raggiungono una dimensione compresa tra i 2 e i 5 mm, mentre le loro regine possono arrivare fino a 1 cm di lunghezza. Tra maggio e agosto, i maschi e le femmine intraprendono il volo nuziale, mentre le operaie sono incapaci di volare.
Ciclo di vita
Nel loro habitat naturale, le formiche costruiscono i nidi nel terreno o nel legno in decomposizione. All’interno degli edifici tendono a insediarsi principalmente nelle fondamenta. Normalmente si nutrono della melata prodotta dalle afidi, ma all’interno degli ambienti domestici le operaie vagano alla ricerca di cibo, in particolare nell’area della cucina. La maggior parte delle specie di formiche è innocua, sebbene possa risultare piuttosto fastidiosa; la loro secrezione acida, tuttavia, non riesce a penetrare la pelle umana integra.
Come intervenire
Non esistono misure preventive specifiche contro l’infestazione da formiche, ma è possibile utilizzare particolari repellenti, come oli essenziali per formiche, per allontanarle. Per eliminarle, nel giardino si possono impiegare spray, polveri o prodotti liquidi, mentre all’interno degli edifici si ricorre a esche per formiche, il cui veleno viene trasportato dalle operaie al nido. Se si osservano numerosi esemplari di operaie nei contenitori di esca, ciò indica una buona accettazione dell’esca stessa.
Tali esche devono essere lasciate per un periodo di almeno un mese, o anche più a lungo, al fine di coprire tutte le generazioni di formiche. Un effetto visibile si manifesta dopo due o tre settimane.
Gli esemplari alati che lasciano il nido durante l’estate non si nutrono e possono essere rimossi facilmente con un aspirapolvere.
Prima di intraprendere qualsiasi intervento di disinfestazione o di allontanamento, è consigliabile che degli esperti identifichino la specie di formica, in modo da scegliere il trattamento più adeguato. Se si tratta di una specie dannosa per il legno, l’intervento risulta assolutamente necessario.

La vespa
Le colonie di vespa di terra, rispetto ad altri vespidi, hanno un ciclo vitale relativamente lungo. La fondazione del nido avviene solitamente già ad aprile, ma al più tardi all’inizio di maggio, da parte di giovani femmine fecondate che hanno svernato. I maschi e le femmine di Paravespula germanica compaiono solo tra la metà di agosto e fine di ottobre. Prima di questo periodo, dalle uova deposte esclusivamente dalla regina si sviluppano solo operaie. Le operaie vivono solo poche settimane, mentre la regina può vivere fino a un anno. I maschi, invece, muoiono a pochi giorni dalla fecondazione delle femmine. In condizioni climatiche favorevoli le colonie possono rimanere attive fino all’inizio di novembre. La vespa di terra non costruisce mai i suoi nidi all’aperto, come fa la Dolichovespula media. I nidi vengono generalmente costruiti sottoterra, all’interno di gallerie di topi o talpe, che vengono sistematicamente ampliate. Tuttavia, vengono anche colonizzati ambienti in superficie come soffitte, intercapedini o altri spazi bui creati dall’uomo. Le grandi colonie possono contenere fino a 7.000 individui. Per forma, i nidi della vespa di terra sono simili a quelli della vespa comune. Come nella vespa comune, la superficie del nido presenta numerose tasche d’aria a forma di conchiglia. Sebbene entrambi i nidi possiedano una simile struttura, è possibile distinguere le due specie grazie al colore della superficie del nido: mentre i nidi della vespa di terra sono di un grigio uniforme, quelli della vespa comune presentano una colorazione giallo-ocra.
Le colonie di vespe, particolarmente numerose e di grandi dimensioni, si sviluppano soprattutto negli anni in cui la primavera è contraddistinta da un clima secco e caldo, poiché queste condizioni favoriscono l’ottimale sviluppo degli insetti. In autunno, le operaie soddisfano il loro fabbisogno di carboidrati principalmente attraverso l’assunzione di alimenti dolci, come frutta, marmellata, bibite zuccherate o torte, comportandosi talvolta in modo fastidioso. In particolare, quando la vespa di terra si presenta in ambienti come aziende alimentari, hotel o panifici, deve essere trattata come un parassita, in quanto può essere veicolo di agenti patogeni e spore di funghi. Sebbene le punture di Paravespula germanica possano essere dolorose, di solito non causano gravi conseguenze per individui sani, ma in caso di puntura nella cavità orale, è assolutamente necessario rivolgersi a un medico. Per persone allergiche, le punture di vespa possono rappresentare un rischio considerevole, potendo scatenare, nei casi più gravi, uno shock anafilattico potenzialmente letale.
Come intervenire
Le vespe, essendo predatrici di altri insetti (in particolare mosche), svolgono un ruolo ecologico fondamentale e dovrebbero essere evitate forme di lotta diretta nei loro confronti. Qualora i nidi di Paravespula germanica non possano essere tollerati nel loro sito, è consigliabile procedere con un trasferimento professionale delle colonie. In ogni caso, è necessario rimuovere il nido affinché l’intervento abbia esito positivo.